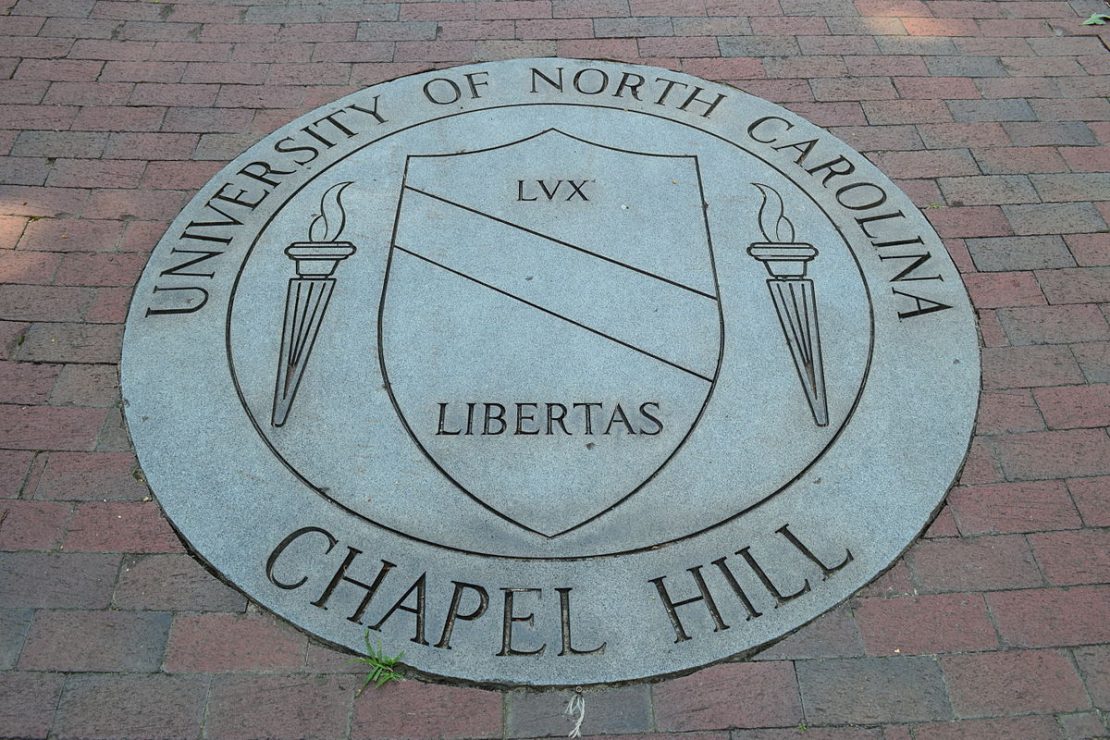L’università di North Carolina, quella di Michaal Jordan, ha vinto per la sesta volta nella sua storia il titolo Ncaa, lo scudetto dei college americani. Una volata in un torneo senza fiato, durato per tutto il mese di marzo, a eliminazione diretta, tra le migliori 68 università americane: è la cosiddetta March Madness, la follia di marzo, che ogni anno inchioda davanti alla televisione milioni di telespettatori negli Stati Uniti. Ha battuto in finale, dopo averla persa un anno fa contro Villanova per un tiro all’ultimo secondo, l’università di Gonzaga, quella di John Stockton, chiamata così proprio in onore di San Luigi Gonzaga. In America la definiscono una Mid Major, un ateneo relativamente piccolo in termini accademici ma con un solido programma sportivo. Gonzaga, che sulla maglia aveva stampato Zags, abbreviazione tutta americana per definirla, era arrivata per la prima volta alle Final Four, dopo un inseguimento durato quasi due decenni sotto il coach Mark Few. Ha giocato alla pari in una finale tecnicamente rivedibile, ma bellissima per intensità, davanti a 77 mila spettatori dello stadio di football dell’Università di Phoenix, a Scottsdale. L’ennesima storia delle mille che ogni anno accompagnano questo torneo, legato alle Cenerentole, le piccole squadre che riescono a qualificarsi al torneo, alle rivalità secolari, all’esplosione di nuovi campioni. Frequentare un’università diventa, per gli americani, un legame che dura tutta la vita, al di la del tifo per altre squadre professionistiche: è qualcosa di diverso, unico nello sport mondiale. North Carolina di Final Four ne ha disputate 20, la prima nel 1946. E’ stata allenata da tecnici entrati nella storia del gioco, come Frank McGuire, Dean Smith e, dal 2003, Roy Williams, al suo terzo titolo, che per 11 anni era stato assistente di Smith prima di perdere contro di lui una finale quando era andato ad allenare Kansas. E già questo racconta la particolarità del basket universitario: se è vero che Gregg Popovich guida i San Antonio Spurs da 21 anni, nel college è normale che un allenatore leghi la propria carriera pluridecennale a una, due squadre. Questo crea uno stile, un marchio riconoscibile, modi di giocare unici ma interpretati sempre da giocatori differenti. Perché, oggi, i migliori restano all’università un solo anno e non i quattro accademici. Il che fa pensare al college basket come qualcosa di immortale dopo l’attacco spaventoso che, nel millennio che stiamo vivendo, ha ricevuto dalla Nba.
Una volta, si passava professionisti dopo la laurea quadriennale o, in caso di condizioni di indigenza della famiglia dei giocatori, dopo tre stagioni. Ma negli ultimi anni, la necessità economiche e le richieste ricevute subito dai pro, hanno portato i più forti (LeBron James su tutti) a saltare l’università entrando nella Nba direttamente dal liceo. La Ncaa si è trovata in ginocchio, senza i migliori atleti, ma anche i professionisti l’hanno pagata perché a fronte delle stelle che ce l’hanno fatta, si sono ritrovati anche con molti giocatori giovanissimi, impreparati. Molti, poi, sono finiti male. Oggi, almeno un anno di università si deve fare. Fondamentale. Significa che dei ragazzi di 20 anni sono costretti a lavorare per una stagione con dei grandi allenatori, da assoluti protagonisti, davanti a migliaia di spettatori sotto una pressione tremenda di riuscita personale e della squadra. Un corso accelerato ma meglio di niente.
Il mordi e fuggi ha cambiato la filosofia di molte università. John Calipari, di Kentucky, ne ha fatta una ragione di vita: dal 2011 a oggi, ha disputato quattro Final Four vincendone una, puntando solo sui migliori giovani della nazione e spedendone ben trentadue nella Nba. North Carolina ha una filosofia diversa. E l’altra via: aspettare la maturazione umana e tecnica dei giocatori, convincerli a restare al college, non ricominciare ogni anno da capo e provare a vincere con atleti e uomini più maturi del terzo anno (junior) o del quarto (senior). Il rovescio della medaglia, è che se sono rimasti al college così a lungo, significa che non sono tanto appetibili per la Nba (o sono di una famiglia che può permetterselo): per molti la carriera sportiva finisce lì. In quello che si chiama Mock Draft, cioè le previsioni per le scelte Nba di giugno, c’è un solo giocatore dei Tar Heels (il nomignolo di North Carolina che si riferisce a come sono chiamati gli abitanti dello stato fin dalla sua nascita) al primo giro, Justin Jackson, uno junior di 22 anni, che peraltro ha “bucato” proprio la finale. Nei primi 10 in ottica Nba, poi dipende dalle varie previsioni, i freshman, cioè quelli che hanno giocato solo un anno al college, sono otto. E i protagonisti delle Final Four soltanto tre su sessanta, poi bisognerà vedere se qualcun altro si “dichiarerà eleggibile” in anticipo, come dicono negli Usa, per i professionisti.
La grande polemica in atto ormai da anni è che i ragazzi delle università percepiscono delle borse di studio per meriti sportivi (e più sono grandi e ricchi gli atenei, più ce ne sono a disposizione) ma non possono ricevere soldi ad alcun titolo, neppure benefit come abiti, auto o semplicemente cene pagate o viaggi. Questo a fronte di un sistema che solo per i diritti televisivi del torneo finale di marzo incassa un miliardo di dollari l’anno, fino al 2032: i diritti del calcio italiani più quelli della Champions sono stati pagati quest’anno circa 750 milioni. Più vanno sommati tutti gli altri contratti-media, le sponsorizzazioni, i biglietti venduti e l’indotto commerciale. Si calcola anche che un buon risultato sportivo possa spostare le iscrizioni al college di qualche migliaia di studenti. Il non pagare giocatori attorno ai quali si costruiscono introiti miliardari in nome della purezza del dilettantismo scolastico è considerata la grande ipocrisia dello sport americano, che ha spesso portato a violazioni e punizioni (cioè vengono dati soldi sottobanco per convincere i più forti a scegliere la propria università invece di un’altra, così come vengono truccati i voti a scuola perché, sotto una certa soglia, gli studenti sono sospesi dall’attività sportiva).
Io credo invece che questa sia e resti la grande forza del basket universitario. Per quei venti-trenta giocatori l’anno che riescono a firmare un contratto con la Nba, ce ne sono migliaia che possono studiare e giocare. Le tasse universitarie di North Carolina, quest’anno, vanno dai 23 mila, per chi è dello stato, ai 53 mila dollari. Per andare a Duke o Harward si arriva a 70 mila dollari l’anno di retta. Un ragazzo che sta tre anni con Tar Heels come Justin Jackson, del Texas, ha finora ricevuto un controvalore di oltre 150 mila dollari, più di quanto avrebbe guadagnato se, mancata la Nba, avesse dovuto giocare nella D-League o in molti campionati stranieri. In più avrà una laurea prestigiosa. Al giorno d’oggi, ne vale la pena. In più, c’è una cassa di oltre 50 milioni l’anno, per aiutare i giocatori a sostenere spese impreviste. Nel mio ultimo viaggio negli Usa, mi sono divertito a seguire partite di college, non solo di big come Syracuse o un po’ decadute come Georgetown o St. John’s.
Ho visto dal vivo Lipscomb, Tennessee State, Stetson, Bryant, Belmont….Il livello è, quando va bene, da serie B italiana, in certi casi anche più basso: sono tutti ragazzini. E se Federico Mussini, il play di Reggio Emilia che ha chiuso la seconda stagione a St.John’s ma già maturo per la serie A, probabilmente non aveva bisogno tecnicamente di andare negli Usa per migliorare (meglio l’Europa, magari non quest’anno che la federazione ha proibito alla Reggiana di fare le coppe…), il fatto di giocare a New York, al Madison Square Garden, con tante aspettative e pressione, gli servirà per tutta la vita, anche come uomo. Le università di Division One sono 351, giocano tutte assieme con differenze abissali tecniche, economiche, di prospettive. I giocatori che perdono soldi al college per non essere potuti passare pro sono due decine l’anno, per gli altri il basket universitario resta un’esperienza magica, unica, che ti regala comunque un futuro. Certo, molti ragazzi provengono da situazioni familiari disastrose e dalla povertà più nera. Non pagarli appare l’ennesima forma di sfruttamento. Ma giocare con altri obbiettivi rispetto ai soldi è una cosa che manca tantissimo in Europa e il segreto del successo immortale del college basket. E di North Carolina.
Luca Chiabotti