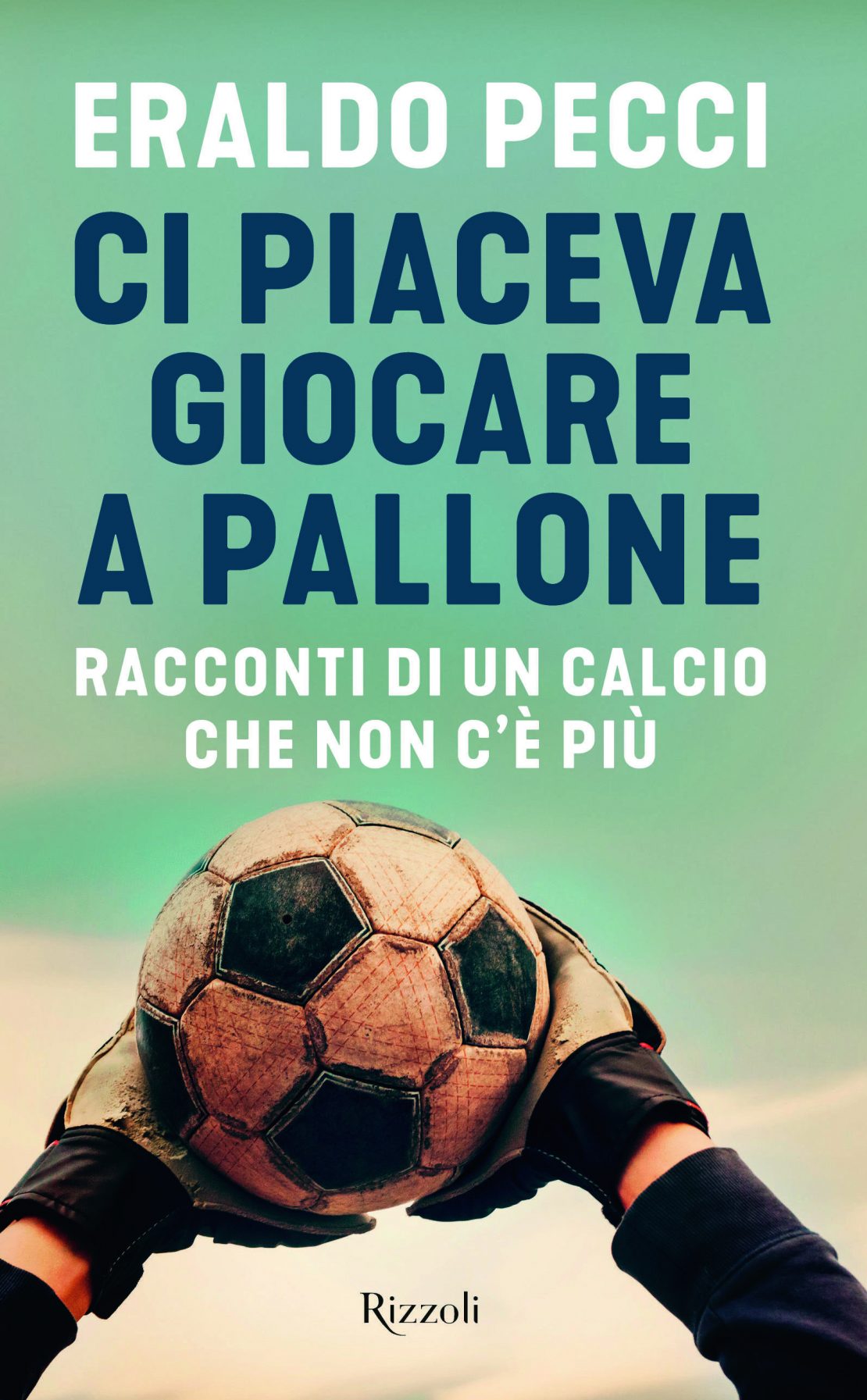La più divertente è il dialogo fra Nereo Rocco, allenatore del Milan, e Gino Pivatelli, centravanti del Milan. “Durante una tournée in Brasile, sempre col Milan dopo i Mondiali del 1962 che i carioca avevano vinto alla grande, Rocco era molto preoccupato perché non aveva difensori disponibili e il centravanti degli avversari sarebbe stato Vavà, così chiese a Gino: ‘Come femo Piva, non gavemognanco uno stopper?’. Gino rispose: ‘Paròn, non xarà miga un problema, stopper pol zogar qualsiasi mona’. E il paròn concluse: ‘Allora te zoghiti!’”.
O forse no, la più divertente è la visita del Bologna al Papa. “Paolo VI, dopo averci dato il benvenuto, si sedette. Noi, al segnale, ci inginocchiammo, ma nel farlo al massaggiatore Gianni Aldrovandiscivolò di mano il regalo che, novelli Magi, avevamo portato. Si trattava di un prezioso candeliere che non cadde a terra perché Gianni fu lesto a riacciuffarlo, ma non controllò altrettanto bene la lingua e nel silenzio generale gli sfuggì un ‘socmel, al candlir…’. Paolo VI non si scompose: ‘Ci sono dei bolognesi tra noi…’”.
O forse no, la più divertente è quel Bologna-Juventus, il pubblico era competente e amava il bel gioco, “vincere era una gioia, perdere una possibilità e non una tragedia”, il Bologna vinceva, la Juventus attaccava, l’allenatore argentino del Bologna “Pesaola era in piedi davanti alla panchina, tutto il pubblico lo vedeva e lui con le mani ci indicava di avanzare ma intanto gridava ‘Chi se move da lì dietro lo maso’”.
La verità è che è impossibile fare una classifica delle storie più divertenti, perché “Ci piaceva giocare a pallone” (Rizzoli, 254 pagine, 17 euro), ovvero “racconti di un calcio che non c’è più”, è un libro divertente, ricco, umano, e poi sano, salutare, valoroso, e ancora sorprendente, affettuoso, perfino commovente. Lo ha scritto Eraldo Pecci, centrocampista con Bologna, Torino, Fiorentina, Napoli e Vicenza, oltre che Nazionale, e ora commentatore televisivo, opinionista e battutista, battitore libero, liberoda marketing, trend, glamour e altre prigioni mediatiche. Uno da bar, da trattoria, da osteria, da tavolata, da spogliatoio, da gita, da trasferta, tutti luoghi e situazioni privilegiate per raccontarsi il meglio della vita.
Pecci lo fa con il calcio, il suo bel mondo rotondo. Il babbo (stalinista) e la mamma (santa), dopo tanti anni la prima volta che finalmente andarono in una trattoria vicino alla stazione, un conoscente li vide e commentò “bella la vita, sempre al ristorante”. La squadra “dei preti” e la squadra “dei frati”, il campo “dei ferrovieri”. Quello che “sosteneva di aver guadagnato giocando a calcio” perché “una volta andò a tirare un calcio d’angolo e vicino alla bandierina trovò cinquecento lire d’argento che un tifoso gli aveva tirato” e “se le tenne”. Quel dirigente della squadra battezzata Superga in ricordo del Grande Torino, che si presentò “piacere, Pellegrini del Superga”, e l’altro, equivocando, gli rispose “anche noi non siamo tanto forti”. Quel giorno in cui Pecci notò “due signori anziani, nascosti dalle piante vicino ai cessi, che cercavano di attirare la mia attenzione. ‘Cosa vorranno quei due busoni?’, pensai”, ma uno era un fondatore del Cesena Calcio, l’altro il presidente della Spal, che voleva parlare con suo padre, offrirgli (a quei tempi) l’astronomica cifra di quattro milioni di lire e acquistarne il cartellino. Quella partita in cui Pecci non aveva scarpe adatte al terreno pesante, “il magazziniere me ne diede un paio numero 45 che appartenevano al libero della prima squadra, Franco Janich, nelle quali dovetti infilare un sacco di ovatta”. Quel bar della Pina, “dove la Pina stessa, quando non aveva voglia di alzarsi dalla sedia alla richiesta di un caffè, ti diceva: ‘Ti do cinquanta lire (costava così), vallo a prendere più avanti’”. Quella mezzala uruguaiana, Raffaele Sansone, che “diceva che nel suo paese facevano giocare in attacco i ragazzi che andavano male a scuola e in difesa coloro che andavano bene perché questo era un modo sicuro per riconoscere il talento. Se gli chiedevi: ‘E in porta?’, ti rispondeva: ‘Il loco’ (il pazzo)”.
Pecci ci regala Franco Cresci, che aveva il compito extra di passare alla sala corse, e Beppe Savoldi, che anche in allenamento pretendeva interventi duri, e Giovanni Mei, “contro il quale era necessario usare i parastinchi anche giocando a tressette”, e Diego Armando Maradona, che alla fine dell’allenamento provava le punizioni, “urlavamo ‘Diego, centra il primo palo’. Colpito! ‘Diego, centra il secondo palo’. Colpito! ‘Diego, la traversa’. Stessa sorte. Sempre così. Un giorno a guardare l’allenamento c’era una scolaresca giunta da Sorrento. A un certo punto sento un ragazzo chiedere: ‘Ma chille nun fa mai golle?’”.
E’ così che Pecci ci riconcilia con il calcio, troppo spesso ormai spettacolo anestetizzato dal tiki-taka, tradito dalle bugie degli allenatori, dalle banalità dei calciatori e anche dai ritornelli dei cronisti, nonché dalla malafede degli arbitri. E’ così che Pecci ci restituisce quelle atmosfere da oratorio che fino ai suoi anni (dai Sessanta agli Ottanta) si potevano ancora respirare ai più alti livelli, coltivare, ricordare e infine riunire così, semplicemente così, candidamente così, calcisticamente così. Sì, ci piaceva – e da matti – giocare a pallone. Sì, proprio così. Sì, e grazie.